Abisso della Vendemmia
L’Abisso della Vendemmia sul Carso Triestino
L’Abisso della Vendemmia
La storia di un’esplorazione tenace
Scoprire nuove grotte non è un’impresa facile; scoprirne una che raggiunga i 200 metri di profondità dopo cinque anni di duro lavoro, ancora meno.
Ecco perché la storia di questo abisso deve essere raccontata.
Ecco perché la storia dei suoi esploratori deve essere scritta.
Scoprire le grotte
Non praticavo ancora attivamente la speleologia, frequentavo le grotte solo da turista, ma ricordo un articolo, che parlava delle cavità scoperte sul Carso triestino, che stimava come le circa 3.000 conosciute fossero solo il 20 – 25% di quelle in realtà esistenti nel sottosuolo.
Non capivo. Com’era possibile che dopo 200 anni di speleologia in quel fazzoletto di territorio alle spalle della città, gli speleo non ne avessero scoperto che un’esigua percentuale?
Mi sembrava impossibile che in due secoli di battute di zona non fossero stati individuati tutti i possibili ingressi.
Oggi, dopo quindici anni di pratica speleologica, di camminate sul Carso e di scoperte di nuove grotte, questi numeri non mi sorprendono poi più di tanto.
Il Carso triestino di oggi è completamente cambiato rispetto a quello dell’800. Un’intensa opera di rimboschimento ha trasformato quella che era un’enorme, arida, pietraia in un’ininterrotta area verde, coperta di boschi di varia natura, pinete, querceti, faggeti; punteggiata solo dagli abitati che nel frattempo si sono estesi e le vie di comunicazione che si sono moltiplicate.
Tranne gli ingressi più evidenti, come la Grotta Noè e l’Abisso Plutone, tutto il resto è coperto da vegetazione, celato alla vista da arbusti, pietrame e alberi.
Ma allora, chiedono i profani agli speleo, come si trova una nuova grotta oggi?
Con metodo. Con costanza. Con competenza e pazienza, tanta pazienza. E un po’ di fortuna! Come fa il nostro Daniele!
È lui il nostro segugio; è lui che gira sul Carso appena dopo una nevicata o quando la brina mattutina ha trasformato il paesaggio in un unico immobile riflesso ghiacciato.
È lui che segna nel suo taccuino, che lui solo può decifrare, i dati che gli permetteranno di capire se quell’anonimo e invisibile forellino tra l’erba è degno di essere indagato oppure no.
È Daniele che si ricorda se quel piccolo foro nel terreno in autunno aspira aria e in inverno la espelle: è Daniele che analizza il respiro delle grotte. Perché molte volte le grotte respirano. Ed è da lui che ho imparato a riconoscere questo soffio rivelatore.
Nelle grotte, anche le più profonde, c’è sempre aria. Sembra un’affermazione banale, ma in realtà in più di qualche occasione profani della disciplina mi hanno rivolto questa domanda.
La geologia del Carso ci ha insegnato che a causa della radioattività naturale contenute nelle rocce, anche in profondità queste hanno una temperatura che resta costante tutto l’anno, che si aggira attorno ai 7 – 8 gradi. Temperatura che viene poi trasmessa per convezione all’aria presente nella cavità.
Ecco quindi che a seconda della profondità della grotta, delle sue dimensioni, della sua morfologia, in definitiva del volume d’aria che contiene, molto spesso, in prossimità dei suoi sbocchi all’esterno, si formano delle deboli correnti d’aria umida, sufficienti, però, a sciogliere la neve in caso di nevicate o la brina nelle fredde giornate invernali.
Tutti indizi che un buon investigatore delle grotte sa leggere e interpretare.
Ma la storia dell’Abisso della Vendemmia è anche una storia di costanza, di estrema, ma ripagata, costanza: dote che al nostro Daniele sicuramente non manca.
La dolina generosa

L’avventura della Vendemmia è ben più articolata dei quasi cinque anni di lavori di scavo al suo interno. L’abisso si apre in una minuscola dolinetta subito dietro la zona industriale di Sgonico, di fronte allo svincolo tra la SS202 e la provinciale che porta a Prosecco, nel comprensorio conosciuto anche come “del Mobilificio Lanza”.
Ben prima del 2000, ai lati di questo avvallamento di appena 10 metri per 6, per un paio di profondità, il San Giusto aveva indagato e scavato seguendo le indicazioni di Daniele: così il bordo più esterno della microdolina ci aveva già regalato il Pozzo del Trittico (RE 5782), una fessura di una decina di metri di profondità che termina in una di quelle strettoie che ti fanno passare ogni voglia di continuare. E a neanche dieci metri di distanza, sempre sul bordo dello sprofondamento, solo Andrea aveva avuto il coraggio di scendere in quello che sarà catastato come il Pozzo O’ Pazzo (RE 6493), anche questo uno strettissimo budello di neanche 9 metri, senza nessuna speranza.
E ancora, sul fondo della dolina, a metà strada fra i primi due, la nostra attenzione si era già concentrata sul Pozzo Cacao (RE 5780) – e non certo per la dolcezza della discesa, bensì per il colore delle tute speleo una volta usciti; cavità che per il momento segna appena una ventina di metri di dislivello, costellati da una serie terribile di massi instabili sospesi, ma purtroppo anche da una corrente d’aria così intensa da non farci demordere.
Fatto stà, tre pozzi in pochi metri quadri, in una dolinetta appena segnata sulla cartina al 5.000. Ce né abbastanza per andare a cercare altrove. Abbastanza per puntare su altre zone da battere.
Tutto ciò per uno speleo qualsiasi, ma non per Daniele.
La scoperta
È domenica sera, una domenica che non mi aveva visto uscire a scavare con gli altri al Cacao. Suona il telefono. È Lupo: “Abbiamo un nuovo buchetto!”. Bene, dico, dov’è, in che zona? La risposta è sconcertante: a quattro metri dall’ingresso del Pozzo Cacao, sul fondo della dolina ma sull’altro lato.
E la colpa di questa nuova scoperta è una comproprietà! Il solito Daniele, infatti, girovagando per quella depressione aveva già da tempo individuato questo nuovo forellino umido, sempre umido, sempre interessato da un notevole flusso di aria relativamente calda che usciva. Ma si era tenuto tutto per sé. Finché non ne aveva parlato con Lupo e lui, a sua volta, con suo figlio, che nel frattempo stava lavorando al Cacao, e che tra una pausa e l’altra nell’opera di disostruzione, aveva cominciato ad allargare proprio dove indicato da Daniele.
Così, pietra dopo pietra, manciata dopo manciata di terra e fango, ecco la parete allargarsi, ecco la luce penetrare in un ambiente un po’ più grande, un ambiente buio, un ambiente nel quale il sassolino lanciato fa un salto e poi atterra, un salto di un paio di metri, forse più, ma comunque un salto: sinonimo di vuoto.
Così inizia la storia dell’Abisso della Vendemmia, che in origine doveva essere semplicemente il Pozzo Cacao 4, la Vendemmia, parafrasi de “Cacao 4, la Vendetta”, dato che si trattava del quarto buco scoperto in quel fazzoletto di terra.
La prima Vendemmia
I lavori alla Vendemmia proseguono per alcuni mesi; è necessario prima allargare l’ingresso in senso orizzontale, per consentire di rimuovere più comodamente le pietre incastrate, ma soprattutto individuare meglio la zona nella quale concentrare i successivi sforzi.

È di questi periodi la prima scoperta sulla circolazione dell’aria. Soprattutto durante la stagione fredda, ma non solo: tanta aria il Pozzo Cacao aspira, tanta la Vendemmia ne espira. E se proviamo a “tappare” il primo con dei teli o dei nylon, quasi immediatamente si ferma il flusso che esce nel secondo. Sintomo che c’è un collegamento fra i due! Sintomo che il collegamento, probabilmente, non è tanto profondo, purtroppo, perciò eccoci per mesi a ragionare sulla triste possibilità che tutta quell’aria, invece che presagire a chissà che ambienti, non sia altro che un banalissimo “giro d’aria” fra due ingressi vicinissimi.

Ecco così giustificate le nostre prove di tracciamento con i fumogeni. Se c’è un collegamento, e se questo collegamento è molto in superficie, allora il fumo colorato risucchiato nel primo dovrà uscire immediatamente dal secondo!
Ho perso il conto dei fumogeni che abbiamo acceso fuori dal Cacao; non ricordo quanto fumo abbiamo fatto inghiottire a quel tubo di pochi metri che con il passare del tempo e la circolazione continua dell’aria, si era nel frattempo completamente asciugato.
Abbiamo acceso fumogeni in tutte le stagioni, ma ricordo solo che dalla Vendemmia non ne è mai uscita una goccia!
Quanti ragionamenti, quante elucubrazioni, quante ipotesi abbiamo buttato sul tappeto per spiegare tutto ciò: due ingressi a pochi metri di distanza, alla stessa quota altimetrica; uno che aspira e uno che sbuffa; se chiudo il primo, il secondo praticamente in contemporanea si blocca, ma nonostante tutto ciò, non un filo di fumo!
La risposta logica che riuscivamo a darci ci portava solo in una direzione: o sotto i nostri piedi dovevano esserci degli ambienti molto grandi, tanto da disperdere il colorante, oppure il collegamento era talmente in profondità da diluire in maniera estrema i fumi.
E ad anni di distanza, e dopo aver superato i 200 metri di profondità, questo dubbio non è stato ancora sciolto!
Lo smottamento
Dopo diverse settimane trascorse ad allargare il probabile accesso, finalmente era giunto il momento di penetrare il buio sul quale mai, prima, occhi umani si erano soffermati.
E il destino ha voluto che questa opportunità fosse di Furio e Gianni. Sono loro che per primi mettono il naso e gli stivali dentro il primo ambiente della Vendemmia.
Si trovano così immersi in una classica, per il nostro Carso, fessura; larga più di un metro, perciò comoda, e lunga quattro o cinque.
Il dislivello da superare, con una semplice tecnica di opposizione fra le due pareti, è di un paio di metri, poi si atterra su un morbido tappeto di terra non compatta e pietrisco.
Passato il primo momento di delusione per il ristretto spazio illuminato dalle carburo – niente caverne, gallerie, niente fiumi – inizia perciò la ricerca delle possibili, probabili prosecuzioni, inizia la ricerca della corrente d’aria che, sempre molto forte, fa tremare i fili d’erba che si piegano lungo le pareti dell’ingresso.
E un certo risultato, queste ricerche, lo producono!
Sul fondo, nella parte più lontana dall’ingresso della fessura, in un leggero sprofondamento, tra le pietre e la terra Furio ha l’impressione di individuare un accenno di pozzo: scatta perciò l’opera di rimozione.
Spalle all’ingresso, appoggiata la schiena allo scalino di terra e pietre dietro di lui, comincia di buona lena a spostare pietre; prima con le mani, poi con la barra di ferro che, comportandosi come una leva, dimezza lo sforzo e raddoppia i risultati.
Prosegue così, per un po’, il lavoro; fino a mettere a nudo i bordi di quello che indubbiamente è un pozzo, perfettamente verticale, di dimensioni quasi umane, che si perde nel nero per almeno una decina di metri.
È fatta!
Sembra l’ora di indossare l’imbracatura e tentare la discesa, perciò Furio si muove dalla sua posizione e cerca di alzarsi, cerca di farlo!
Cerca di alzarsi perché solo allora si accorge che la sua schiena, tolte le pietre da sotto i suoi piedi, aveva oramai assunto le funzioni di sostegno per tutto il restante materiale.
Ancora oggi Gianni, il testimone oculare del fatto, assicura di non aver mai visto il nostro Presidente muoversi così velocemente! Lo ha visto schizzare via giusto in tempo perché gran parte del terrapieno, dove anche lui stava per aiutarlo nell’opera di spietramento, non franasse sopra al pozzo appena aperto che, come le fauci spalancate di una creatura protagonista di una qualche scadente pellicola horror, senza grossi sforzi, non lo inghiottisse.
Il primo rilievo
Dopo questo episodio, tante altre uscite si sono susseguite, fino a quando l’oramai famoso pozzetto non è stato reso transitabile. Le sue dimensioni, che da una prima analisi sembravano sufficienti a farci passare, in realtà avevano in più di qualche occasione fermato il nostro incedere.
Avevamo dovuto allargare strozzature, rimuovere spuntoni, far precipitare pietre che, lungo quel budello, solo pochi granelli di terra umida trattenevano dal cadere.
In questo caso l’onore della prima discesa è per me e Papo, anzi è lui che scende per primo, e solo dopo che si è allontanato dalla verticale, scendo io.

Che strana la prospettiva! Quello che dall’alto sembrava un passaggio di una comodità unica, man mano che scendo diventa sempre più un calzino aderente al mio corpo. Devo girare il baschetto da un lato, ad un certo punto della discesa, perché altrimenti si incastra.
Per fortuna, dopo un ultimo punto stretto, la parete che sta alle mie spalle si allarga; l’ambiente diventa più largo, assolutamente comodo. Come potrò capire una volta giunto sul fondo, è chiaro che questo vuoto più ampio è il risultato del crollo di un paio di diaframmi paralleli di roccia, che perciò hanno dato più respiro al nostro procedere.
Nonostante ciò, la delusione rimane. A parte i circa venti metri di dislivello, anche questo nuovo vano è decisamente contrassegnato da un pavimento completamente composto di materiale di crollo, materiale che non lascia trasparire nessuna possibile via di prosecuzione.

Nemmeno i due piccoli saltini che contraddistinguono la parte più estrema del fondo sono portatori di buone notizie, visto che terminano in quelle fessure di pochi centimetri che già troppo volte ho avuto modo di vedere nelle cavità del Carso. Sono ringiovanimenti, zone che, nuovamente interessate da stillicidio, hanno perso il velo di calcite che le ricopriva, rimettendo a nudo il grigio calcare, che si è trasformato in un’infinita sequenza di bordi taglienti; bordi che ti strappano la tuta solo a vederli.
Si tirano le misure per il rilievo, scatto un paio di foto per documentare anche agli altri l’ambiente, per poter decidere a tavolino sul da farsi, poi risaliamo, consapevoli che di correnti d’aria, là sotto, non c’è traccia.
Ma allora, tutto il movimento d’aria che sentivamo le prime volte, che sentiamo ancora quando ci affacciamo all’ingresso della cavità, da dove arriva?
La telecamera
Un noto detto sancisce che la fortuna è cieca, ma la sfiga …. . La pianta del primo vano scoperto dell’Abisso della Vendemmia, si presenta come una fessura larga poco più di un metro, lunga cinque o sei, con quasi ad una estremità l’accesso del pozzo da circa 20 metri.
Vista tutta questa comodità, perciò, da dove poteva uscire quella forte corrente d’aria che tanto volevamo seguire?
Ovviamente dal posto più scomodo, nascosto, inaccessibile, intransitabile.
E alla fine Daniele lo ha rintracciato, dietro una lama, che a malapena ci lasciava lo spazio per infilare la testa. Un metro dietro questo angolo di roccia, sul fondo, tra due lame di roccia erosa, un piccolo foro, roba di 10 – 20 centimetri. Un foro dal quale costante, imperterrito, soffia l’alito del buio.
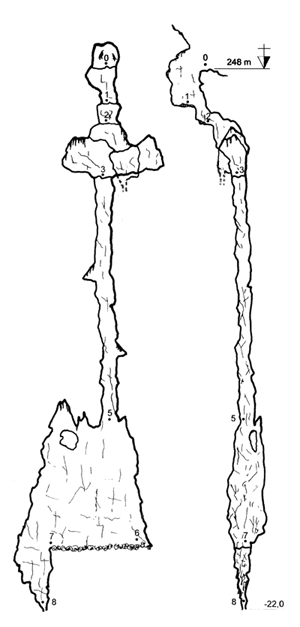
È chiaro, a questo punto, che se si vuole continuare, è necessario cominciare il lavoro di allargamento da lontano; è necessario rimuovere la roccia non solo quel tanto che basta per consentire il passaggio, ma anche per consentire di lavorare con una certa comodità sul foro. Bisogna, quindi, allargare molto più del necessario, per evitare che poi non si riesca a sistemare le gambe, o la schiena, o la testa.
Inizia così una sequenza di uscite nelle quali si cerca intanto di “arrivare sul problema”. Si cerca di crearsi lo spazio fisico per almeno poter guardare in faccia l’accenno di prosecuzione.
E alla fine ci siamo!
Iniziamo ad allargare in verticale, ma non riusciamo a capire come il pozzetto prosegua; non riusciamo a individuare la strada migliore da seguire, o semplicemente a vedere per quanto, in profondità, l’ambiente continuerà ad essere stretto.
Ecco allora il rimedio: siamo speleo del terzo millennio, perciò dobbiamo affidarci alle tecnologie più sofisticate!
Ci viene incontro Schumi, con la sua competenza e le sue attrezzature audio-video. Vengono studiati sistemi basati su telecamere agganciate a un filo guida, telecamere su sostegni telescopici flessibili da manovrarsi dall’esterno, telecamere a infrarossi, con led, a colori, in bianco e nero.
Vengono ipotizzate soluzioni di tutti i tipi, di tutte le fogge, ma poi, finalmente, si decide di procedere; così, invece dei soliti sacchi speleo, dai bagagliai delle macchine ecco sbucare matasse di cavi coassiali, connettori BNC, accumulatori, schermi, monitor, telecamere.
Si allacciano i cavi, si provano le apparecchiature, si testano i sistemi, fino a infilare il tutto nel piccolo pertugio.
Sottoterra c’è chi cala la sonda, all’esterno tutti gli altri che controllano i risultati in tempo reale, tutti attorno al monitor di pochi pollici: sembra di assistere allo sbarco sulla Luna!
Purtroppo, però, anche questi gioielli tecnologici non ci aiutano a individuare chissà che enormi ambienti. Le immagini che otteniamo mostrano solamente un paio di metri di budello roccioso e poi uno spigolo, un angolo, una pietra, chissà, blocca l’avanzare dell’occhio elettronico.
È necessario cambiare tattica, è necessario modificare lo strumento per la discesa. Così, la settimana successiva, si ritenta con un sistema a doppio cavo, che immaginiamo possa dare frutti migliori.
Altro materiale, altre diavolerie elettroniche, altra attesa.
Il cavo inizia a scendere, le immagini scorrono sul monitor. Rivediamo gli spuntoni della volta precedente. Arriviamo dove ci eravamo bloccati e dopo un paio di tentativi falliti, ecco che la discesa riprende.
L’eccitazione è alle stelle, ci aspettiamo chissà che sorprese, chissà che spettacolari visioni, chissà che ……. che schifo!
Dopo neanche un paio di metri un altro stop. Uno scalino che neanche tutti i nostri tentativi riescono a superare ci blocca. Ci rassegnamo al fatto che neanche la tecnologia più avanzata ci aiuta: sarà necessario, come sempre, scavare, scavare e ancora scavare. Pazienza!
Non ci rimane che recuperare la telecamera. Inizio a recuperare il cavo, ma dopo mezzo metro si blocca. Il cavo si tende, si stira ma non si libera. “Sarà impigliata in qualche piccolo spuntone”, penso, perciò rilascio e riprendo il cavo più e più volte per liberarlo. Niente! Sempre incastrato.
Mollo lentamente, velocemente, di colpo riprendo a tirare, attorciglio il cavo, lo faccio saltare: niente! È sempre bloccato!
Ci diamo il cambio, proviamo con delle prolunghe rigide per vedere di liberare il cavo più in profondità. Ancora nessun risultato. Proviamo addirittura ad agganciare al cavo incastrato un’altra cima con un peso, per vedere se questa massa supplementare possa smuovere la situazione.
Nulla, la telecamera non si schioda dalla sua posizione, lasciando sul monitor una desolante inquadratura fissa su pietrisco e terra, quasi un fermo immagine.
E quella sarà l’ultima immagine che trasmetterà. Dopo altri innumerevoli tentativi, protratti per settimane, saremo costretti a tagliare i cavi e ad abbandonarla al suo destino.
Sono passati anni da quel momento; il pozzo, oramai chiamato “delle clanfe”, è un salto di circa quattro metri, di pianta ellissoidale, con il diametro maggiore di almeno un paio di metri, leggermente imbutiforme, ma della telecamera non abbiamo mai avuto notizie.
Certo, tantissimo materiale è finito in quel originariamente angusto budello, ma, per proseguire, altrettante pietre e terra sono state rimosse.
Inutilmente, della telecamera non abbiamo più trovato traccia, inghiottita per sempre dalla Vendemmia.
Il primo pozzone
 Passano i mesi, e i lavori proseguono. Si continua a lavorare sul fondo del Pozzo delle Clanfe. Anzi, da questo ci si sposta, in pianta, di un paio di metri, per individuare un altro pozzetto di 3 – 4 metri, che dovrà essere liberato da lame di roccia e massi incastrati, che con ingegnosi sistemi di carrucole e passamani vengono “archiviati” nell’ormai abbandonato pozzo da 20, che cominciamo a capire scendere parallelo a noi.
Passano i mesi, e i lavori proseguono. Si continua a lavorare sul fondo del Pozzo delle Clanfe. Anzi, da questo ci si sposta, in pianta, di un paio di metri, per individuare un altro pozzetto di 3 – 4 metri, che dovrà essere liberato da lame di roccia e massi incastrati, che con ingegnosi sistemi di carrucole e passamani vengono “archiviati” nell’ormai abbandonato pozzo da 20, che cominciamo a capire scendere parallelo a noi.
Quasi a voler prendersi gioco di noi poveri speleo, ecco che dobbiamo nuovamente spostarci in orizzontale, tornando perfettamente sulla verticale delle “Clanfe”, e qui, su un comodo pianerottolo formato di lame erose, ecco riapparire la prosecuzione verticale.
Di fronte a noi uno strato compatto di calcare, in mezzo lame e aria. Ci vorranno diverse settimane, durante le quali sarà necessario eliminare qualche centinaio di chili di lame erose, più o meno stabili, più o meno friabili, e finalmente atterriamo su un fondo.
Intendiamoci, niente di eclatante. Uno spazio che a malapena ti fa inginocchiare per raccogliere le pietre che noi stessi abbiamo smosso qualche metro più in alto.
Ma tanto basta per approfondirci un po’, per poter continuare , secchio dopo secchio, a guadagnare centimetri di profondità.
Così, una domenica, dopo tanto lavoro e poco prima di risalire per riprendere dopo altri sette giorni, scendo sul fondo per dare il cambio al compagno d’avventure di turno e per dare un’ultima occhiata al problema.
Ecco così che individuo uno spazio, un buco della serratura dal quale sembra uscire l’aria che sempre ci accompagna. Sembra? Altro che sembra! È proprio da là che arriva!
Non ha più importanza se sia tardi, comincio a rimuovere pietre, prima più piccole, poi sempre più grandi, finché non metto in risalto una specie di passaggio basso orizzontale.
Un diaframma di roccia aveva ceduto, liberando il passaggio che stavamo scavando. Un passaggio squadrato, quasi tagliato col coltello.
Il varco, però, è a livello del pavimento, rasoterra; perciò per guardare oltre è necessario sdraiarsi e infilarsi, come un verme, in quello spazio di 30 – 40 centimetri.
Devo muovermi con cautela, le pareti non sono ancora del tutto sicure, ma soprattutto le misure dei miei arti inferiori e quelle dell’ambiente in cui mi trovo non vanno molto d’accordo. O sono troppo alto, o il pozzo è troppo stretto!
Fatto sta che dopo qualche tentativo andato a vuoto, eccomi prono, con le braccia lungo i fianchi, spingermi con movimenti degni di un invertebrato con la testa infilata in quell’oblò, con lo sguardo sul nulla, sull’ignoto.
A complicare il tutto l’andamento a cucchiaio del pavimento sul quale striscio, che vorrebbe piegare la mia colonna vertebrale come se fossi un contorsionista.
Cerco punti d’appoggio con i piedi, in modo da potermi spingere in avanti, ma allo stesso tempo cerco di essere attento ad ogni rumore che possa arrivare dal diaframma che mi sta sopra la schiena come una ghigliottina calcarea. Non sarei entusiasta se qualche allegra pietruzza decidesse si precipitare proprio sulle creste delle mie vertebre!
Spingo con i piedi e allo stesso tempo cerco di non finire con la faccia contro le pietre e la terra del fondo, ma posso fare affidamento solo sui miei addominali, dato che le braccia sono immobilizzate lungo i fianchi e mi devono servire per fare retromarcia da quella situazione.
Spinta dopo spinta, sbuffo dopo sbuffo, ecco che il casco passa il punto più stretto, ecco che sembra si stia allargando.
Ho acceso anche l’illuminazione elettrica frontale, così ho un po’ più visibilità, soprattutto in profondità, così potrò finalmente vedere e, forse, gioire!
Controllo verso destra, verso sinistra; punto il fascio luminoso il più possibile verso il basso e verso l’alto. Dopo mesi di lavori in ambienti stretti, stretti e ancora stretti, finalmente intravedo un ambiente più grande.
Sembra, e sarà, una frattura che si allunga per 7 – 8 metri, larga anche 1 e mezzo o 2, che non riesco a capire per quanto si perde verso l’alto – in realtà si tratterà di più di cinque metri – ma che ha un fondo almeno un paio di metri sotto il mio sguardo.
Ma soprattutto, la strettoia nella quale sono infilato è chiaramente la prosecuzione: tutta l’aria che abbiamo sempre seguito è là, attorno al mio corpo, che aderendo quasi completamente al passaggio crea un tappo. È talmente forte che quando il passaggio è libero piega la fiamma della carburo.
La notizia del nuovo ambiente, com’è ovvio che sia, si sparge immediatamente tra i soci del gruppo e la settimana successiva, perciò, l’affluenza alla Vendemmia è superiore al solito. E tra i tanti scavatori c’è anche Furio, che una volta allargato il passaggio orizzontale, cerca di individuare l’origine dell’aria nel nuovo ambiente.
Capita così che c’è chi guarda da una parte, chi smuove terra dall’altra, chi lancia sassolini in piccole strettoie fra le concrezioni per vedere se dietro al buio c’è dell’altro.
E proprio uno di questi sassolini, lanciato fra due piccole colonne, invece di rotolare per pochi centimetri, precipita, muto, per alcuni secondi, restituendo poi agli esploratori un’eco sorda di un fondo molto più profondo.
“Silenzio, tutti fermi!”, urla Furio, mentre cerca altre pietre da lancio. Un tentativo, due, tre, poi nuovamente riesce a trovare la traiettoria giusta.
La pietra sparisce nella piccola fessura e poi … boom … booom … booooom!!
C’è un pozzo, c’è un pozzo profondo, ma soprattutto deve essere largo! Il rumore dei rimbalzi e del tonfo finale sono inequivocabili.
È inutile dire che questa scoperta non fa altro che rigenerare il morale e le forze dei nostri scavatori, che così, per alcune settimane, si dedicano ai lavori di apertura di un passaggio per raggiungere il pozzo.
Ben presto, però, risulterà evidente che la strada migliore da seguire non è quella percorsa dal sassolino, tra le concrezioni, in una stretta fessura, bensì quella che ci porta ad affrontare “lo stretto” più in basso.
È cioè più semplice scavare verso il basso, in modo da allargare lo spazio a nostra disposizione.
In breve la fessura che avevo solo intravisto la prima volta che mi ero infilato nell’ex passaggio orizzontale, cambia completamente aspetto.
La parte più lontana dalla oramai certa prosecuzione diventa il deposito dove accatastare le pietre e i massi che vengono rimossi dal pavimento della parte opposta del fuso.
Inizia così a veder la luce un passaggio più agevole, una finestra sul pozzo che stavamo cercando. Ma le pareti di calcare sono ancora troppo vicine, non permettono nemmeno di infilare la testa; è necessario un duro lavoro di mazza e punta per addolcire la strettoia.
E più materiale rimuoviamo, meglio si definiscono le forme del pozzo che abbiamo intercettato.
Alla fine, dell’originario passaggio, non resta nulla. Oramai abbiamo aperto una finestra, comunque non comodissima, sul vuoto; quello che inizialmente reputiamo il solido pavimento di questa finestra, quello che pensiamo sia un solido strato calcareo, in realtà si rivelerà nient’altro che un masso incastrato nella parte più stretta della frattura.
Una specie di pianerottolo instabile, un trampolino verso il nulla, il buio, l’inesplorato.
Una domenica, finalmente, è il momento di scendere, di vedere dove ci conducono le pareti concrezionate che solo da lontano riusciamo a illuminare.
Tocca a me, sarò io il primo, forse perché sono tra quelli che da più tempo si immerge in questo buco.
Mi preparo con tutto l’occorrente per la prima discesa. Discensore, kroll, maniglia; e poi spit, battispit, moschettoni, placchette, fettucce. Ogni mio movimento è sottolineato da un tintinnio metallico.
Mi avvicino alla finestra, sistemo tutta l’attrezzatura, la ricontrollo. Non è la prima volta che mi calo per primo in un nuovo pozzo, ma stavolta le aspettative sono importanti.
L’emozione c’è, anche perché sappiamo che non si tratta di un saltino da niente, ma di almeno 30 – 40 metri.
Per superare la strettoia, passo una gamba al di là del punto più stretto, poi mi piego in avanti, mi metto di “taglio” e cerco di passare con tutto il resto del corpo e della ferraglia che ho appesa a mo’ di tracolla.
Con le mani cerco un appiglio sicuro, più che sicuro, e lo trovo in alcune canne d’organo concrezionate davanti a me. Ancora un piccolo sforzo ed è fatta. Sono passato!
Sono con due piedi nell’ignoto, su un ballatoio di pochi decimetri quadrati, quanto basta per i miei stivali.
Dall’altra parte della strettoia tutti gli altri sono già a chiedermi cosa vedo, come continua, quanto è profondo.
Con un faro illumino dritto avanti, sopra, verso il basso. Lentamente il pozzo si svela.
D’innanzi a me ci sono almeno sei – otto metri di frattura che va restringendosi fino a chiudersi. Io sono nella parte più ampia di un’ellissoide molto allungato e sopra di me il pozzo prosegue per almeno altri 5 o 6 metri, fino a perdersi in uno dei soliti camini carsici impraticabili.
Ma la vera sorpresa è sotto i miei piedi, perché le pareti si allargano, cavolo se si allargano! Si allontanano e non sembrano assolutamente voler impedire il nostro procedere. Finalmente un pozzo transitabile!
Comincio a guardarmi in giro alla ricerca di un armo; studio varie soluzioni, diverse vie d’attacco, poi parto. Mi spingo in avanti più che posso, in spaccata sul vuoto, finché raggiungo una colonna che mi ispira fiducia.
Fettuccia, moschettone, nodo a otto. Fatto il primo armo!
Comincio a scendere ma cerco di spingermi subito contro la parete di fronte, perché là, sei – sette metri sotto, ho individuato il possibile secondo attacco. Altro armo naturale e ancora discesa.
La corda si sfila dal sacco che ho appeso sotto di me, scorre attraverso le pulegge del mio discensore e si perde nel buio sopra la mia carburo mentre io continuo a calarmi.
La discesa è lenta e giro su me stesso per guardarmi attorno. Oramai una decina di metri sopra la mie testa, la luce degli altri compagni di avventura che non fanno altro che chiedermi se sono arrivato sul fondo, se possono scendere, se è “libero”!
Attorno a me le pareti si sono di molto allargate – due o tre metri; sotto la verticale dell’ingresso nel pozzo, l’acqua ha eroso il calcare come fosse burro, lasciando incisa nella roccia un’impronta verticale di una decina di metri quasi perfettamente circolare: sembra sia passata una gigantesca trivella.
Scendo ancora e incontro una frana di enormi massi che invano vuole nascondermi una sala laterale. Le pareti sono completamente concrezionate e assolutamente asciutte. Proseguo ancora verso il basso.
Pianto uno spit su una cengia che mi lascia scendere in libera per un’altra decina di metri, poi la morfologia del pozzo, quasi istantaneamente, cambia completamente.
I banchi compatti e concrezionati di calcare lasciano spazio e strati sempre più sottili, molto fratturati, fragili, nuovamente interessati da uno stillicidio che si è mangiato il velo calcitico che li rivestiva.
Come tocco con i piedi le pareti, stacco qualche blocco di roccia e fango, ma quel che forse è peggio, le pareti vanno restringendosi, quasi fossero un gigantesco imbuto.
Illumino verso il basso e intravedo un fondo, un fondo di pietrisco. Un pavimento di rocce frantumate che però mi sembra avere due livelli.
Continuo a scendere finché non tocco terra sul ripiano più alto.
Sono in una specie di tappo di pietre, quasi circolare, del diametro di poco più di un metro, un metro e mezzo. Sembra che tutto finisca qua! Ma come è possibile? Tutto questo pozzo, tutta l’acqua che lo ha eroso non può aver scavato fino a qui e basta: comincia a farsi strada l’idea che quella sotto i miei stivali sia un’enorme frana che blocca la prosecuzione. E se così fosse, ben poche sarebbero le probabilità di proseguire, dato che di spazio per accatastare pietre non ce n’è tanto.
Cominciano già a farsi strada nella mia testa pensieri carichi di delusioni, di speranze andate infrante, di tanto lavoro interrotto da una frana insuperabile, quando mi accorgo che una luce si avvicina dall’alto.
È Edo, che non riuscendo più a trattenere la curiosità per la scoperta della scoperta, aveva cominciato a calarsi e, armo dopo armo, era arrivato sopra la mia testa.
Il piccolo pianerottolo che occupo non è sufficiente ad accoglierci entrambi, perciò lui procede fino al secondo fondo, quello un paio di metri più sotto.
Anche il suo entusiasmo, ovviamente, non è alle stesse quando appoggia i piedi su quel cumulo di pietre e terriccio. Però, dopo un momento di smarrimento, si mette imperterrito a rovistare tra i sassi. Anche secondo lui non può finire così, magari tra le pietre troviamo un varco, un passaggio, un bypass sotto a questa maledetta frana.
Sposta qua, spingi là, il nostro Edo muove qualcosa proprio in corrispondenza della parte più bassa del fondo nel quale si trova e, neanche avesse tolto un tappo da un contenitore in pressione, eccolo investito nuovamente da un getto d’aria, la solita vecchia corrente d’aria che oramai da mesi stavamo seguendo.
L’entusiasmo si fa nuovamente avanti, il sorriso si ristampa sulle nostre stanche e sporche facce. Sarà necessario un duro lavoro di scavo, ma forse non tutto è perduto.
Il secondo grande pozzo
E il lavoro risulterà effettivamente arduo. Una serie di uscite metterà in luce un passaggio sub-verticale, quasi un tubo, che però sembra quasi circondato da roccia sana.
La buona notizia, quindi, è che ci stiamo togliendo da sotto il tappo instabile rappresentato dal fondo del primo pozzo; la cattiva è che stiamo lavorando in un piccolo pozzetto caratterizzato da una serie di lame di roccia, di diaframmi di calcare che lasciano poche decine di centimetri tra l’uno e l’altro, costringendoci a utilizzare tutti gli spazi, tutte le nicchie, tutti gli interstizi disponibili per accatastare il materiale che rimuoviamo per allargare il passaggio.
Sarà un lavoro certosino quello di Papo, di Mauro, delle stesso Edo, di Max e Clarissa e tutti gli altri ma alla fine una saletta laterale, di circa un metro per uno, sarà quella che meglio farà da deposito – una saletta di sui sentiremo ancora parlare – restituendoci così un pozzetto di circa sei metri, largo quanto basta per la discesa e la salita.
Sul fondo di questa verticale, le pareti si allargano un minimo, ma oltre, sempre verso il basso, si continuano a vedere solo altre lame, altri diaframmi, altro materiale lapideo incastrato.
È desolante, non si riesce a vedere la fine del tunnel; mai un indizio che possa presagire a qualcosa di più largo, di più transitabile. Verso il basso tutto è sempre stretto, sempre intasato.
Ma se la via verticale è così ostica, perché non tentare anche altre strade? Perché non battere altre piste?
E finalmente gli sforzi diretti in altre direzioni hanno successo!
Su un lato, un piccolo foro sembra presagire a un ambiente più largo. Il pertugio si allarga, cede sotto i colpi dello scalpello e della strangola e finalmente lascia passare un caschetto. E quello che illuminiamo ci sorprende.
Un pozzo, largo, transitabile, che addirittura dopo neanche un paio di metri scampana.
Tutto bellissimo, dunque? Sì, fino a quando non giriamo lo sguardo verso l’alto e non diamo un’occhiata anche sopra alle nostre teste!
Pietre, pietre grandi, enormi; incastrate, appoggiate le une sopra le altre, in equilibrio, tenute su da qualche minuscolo sassolino in equilibrio instabile.
Accidenti, è un pozzo parallelo a quello nel quale siamo scesi, e quelle rocce sospese sono in esatta corrispondenza con la piccola saletta che abbiamo utilizzato come deposito.
Come dire: abbiamo caricato la frana sopra la nostra testa con qualche altro quintale di pietre.
Ci siamo fregati con le nostre stesse mani.
È ovvio che per proseguire è necessario risolvere il problema, è necessario rimuovere la calcarea spada di Damocle che abbiamo contribuito a creare. E probabilmente l’unico sistema per rimuoverla è far precipitare tutto ciò che è instabile, pulire il soffitto da tutto quello che si muove e che potrebbe finire sui nostri caschi.
È domenica mattina. Una delle tante di lavori alla Vendemmia. Siamo solo io e Mauro e il nostro obiettivo è sempre lo stesso, cercare di mettere in sicurezza questo benedetto soffitto incombente e instabile.
Innanzitutto iniziamo ad allargare ancora il passaggio che dà accesso al nuovo e ancora inesplorato pozzo, in modo che i nostri movimenti siano i più liberi possibile e non ricostringano a mettere le mani o i piedi dove non dobbiamo.
Più insistiamo nei lavori di ampliamento, meglio riusciamo a vedere il pozzo che scende. E più vediamo il pozzo che scampana e si perde nel buio, più è difficile trattenersi dallo scendere. La voglia di proseguire, di violare l’ignoto è sempre più forte.
Tant’è che ad un certo punto Mauro non riesce più a trattenersi. Sia quel che sia, vuole cominciare a scendere, non può più aspettare.
Prepara discensore, maniglia, battispit e fettucce e si infila nel passaggio. Alcuni istanti per passare il diaframma roccioso ed eccolo dall’altra parte.
Certo, il soffitto che si trova sopra la testa non è un granché invitante, ma oramai è fatta.
Parte il primo spit. Corda, moschettone, passaggio dell’armo e giù!
Sono steso con la testa infilata nel passaggio e lo guardo mentre la sua lampada diventa sempre più piccola. Continuo a chiedere cosa vede, come prosegue, quanto allarga, e non ricevo che risposte di pareti sempre più lontane, di un pozzo che gira, di un fondo che ancora non si vede.
È oramai oltre una decina di metri più sotto quando batte un altro spit; ancora un’altra discesa in appoggiata, un altro armo in libera e poi dritto giù, in verticale.
Non vedo più la sua luce. Tutto è silenzio.
Comincio a chiamarlo: “Mauro! Mauro! Sei arrivato?”. Silenzio. “Mauro, tutto bene?”. Ancora silenzio, poi, lontani, cupi, una serie di borbottii, di imprecazioni. È finito in una caverna! Grande, grandissima, larga, alta, disseminata di enormi massi di crollo ma……. ma la corda si ferma a un paio di metri da terra!! Non può proseguire, deve risalire.
Le caverne
Mauro è risalito fino a dov’ero fermo. Imprecando e sbuffando. Ma è deciso a ritentare, anche se quel soffitto sopra la sua testa si fa sempre più minaccioso.
Decidiamo perciò di recuperare un paio di metri di corda degli armi a monte.
Risalgo il breve pozzetto di collegamento tra i due pozzi e comincio a rifare i nodi. Nel frattempo Mauro, armato di strangola, cerca di far precipitare più materiale possibile; tanto, oramai, ha visto che non c’è il minimo dubbio che tutte queste pietre possano ostruire qualche prosecuzione.
Per non intralciare il suo lavoro, pertanto, mi fermo sul fondo del primo pozzo e, dall’alto, lo guardo mentre rifila colpi a tutto quello che gli sembra in procinto di staccarsi.
Per stare più comodo, mi appoggio alla cima che arriva dal P40 e resto a sentire i tonfi delle pietre che via via cadono per il successivo P30.
Va avanti così per qualche minuto, finché, all’improvviso, la strangola va evidentemente a toccare la chiave di volta di tutta la frana, che senza più il suo supporto, cede sotto il peso di tutto il materiale che gli sta sopra.
Dalla mia posizione rialzata, 6 o 7 metri sopra al mio compagno di avventure, riesco solo a vedere Mauro che come una molla si butta dalla parte opposta del passaggio appena aperto. Immediatamente dopo un rombo; un tuono; un boato che lentamente cresce di intensità.
Qualche metro cubo di materiale, improvvisamente, si muove, cede, precipita con un fragore crescente, amplificato dal rimbalzare di centinaia di massi e pietre sulle pareti del pozzo.
È un attimo e lo spostamento d’aria di questo improvviso movimento mi investe.
Di colpo la carburo si spegne lasciandomi immerso in un buio rotto solo dalle oscillazioni della corda sulla quale sono appoggiato, che sembra muoversi sotto l’effetto di un terremoto.
Passano alcuni istanti, poi riaccendiamo le lampade. È tutto a posto, nessuno si è fatto male. Mauro infila nuovamente la testa nel passaggio ed esulta: quasi tutta la frana se n’è andata, rimane solo qualcosa da rimuovere: ci si può calare in sicurezza!
Scende sempre lui per primo, riutilizzando gli spit che aveva già battuto, ma subito dietro scendo anch’io.
L’ingresso è un po’ scomodo, ma subito ci si trova in un tubo largo, che non impedisce o ostacola i nostri movimenti. Inizio a scendere e le pareti subito si allontanano. Sono caratterizzate da una assoluta e completa erosione che lascia in vista degli strati calcarei di potenza metrica, costellati di fossili che emergono dalla roccia come se ne volessero uscire.
Passo un frazionamento e alla mia destra posso ammirare un approfondimento del pozzo, un crollo che lo allarga di altri sette o otto metri. Proseguo fino al frazionamento che Mauro ha piantato su quello che sembra un portale di pietra.
Passo il nodo e ricomincio a scendere e come mi giro su me stesso, ecco che davanti ai miei occhi si apre una caverna.
La luce di Mauro non riesce a illuminarla tutta. Scendo più veloce che posso e mi stacco dalla cima. Siamo i primi, siamo noi i primi a vedere questo ambiente, a camminare su questi crolli.
Come bambini in un negozio di giocattoli, cominciamo a correre da una parte all’altra dell’ambiente, alla ricerca di una prosecuzione che speriamo di trovare bella e pronta.
Il pavimento è ingombro di massi e noi siamo atterrati vicino ad una parete del vano. Davanti a noi prima una specie di avvallamento, una sorta di leggero imbuto, poi una salita; massi da superare, da arrampicare. Poi nuovamente il pavimento si fa piano, sino a terminare in passaggi bassi da percorrere carponi. Niente di eclatante, comunque.
Mi giro nuovamente nella direzione dalla quale siamo scesi e vedo che, tra il soffitto che scende e il pavimento che sale, resta una fessura, uno spazio di qualche decimetro ma estremamente nero, troppo nero.
Mi incuriosisce, perciò mi avvicino e richiamo l’attenzione di Mauro che nel frattempo “ravanava” da un’altra parte. Arrivo di fronte a questa fessura; è al livello del pavimento. Mi abbasso per controllare meglio e mi accorgo che dietro c’è ……. dietro non c’è niente, è buio! È vuoto!
“Continua, Mauro continua di qua!” grido, e nello stesso tempo comincio a infilarmi, senza aspettare, tanto che sento Mauro che di corsa si sta avvicinando, seppellendomi di non proprio simpatici epiteti visto che non lo sto aspettando.
Striscio per circa un metro in un passaggio basso, ma subito dopo ecco che il pavimento si abbassa e il soffitto di alza. Siamo, anche Mauro mi ha raggiunto, in un’altra caverna, di dimensioni leggermente inferiori alla precedente, di forma allungata.
Su un lato parete quasi verticale, dalla parte opposta una china detritica inclinata di almeno 40°. Nella parte più lontana rispetto al passaggio dal quale siamo arrivati, un passaggio più stretto, concrezionato, caratterizzato da alcune stalagmiti di oltre un metro di altezza ci conduce a una colata calcitica alta 5 o 6 metri, larga almeno tre o quattro, che non lascia intravedere alcuna prosecuzione: un camino completamente chiuso.
I nostri sentimenti sono contrastanti.
Da un lato c’è l’euforia della nuova scoperta, della scoperta di ambienti grandi, orizzontali, calpestabili.
Dall’altro la delusione per non aver trovato prosecuzioni chiare e decise; quelle gallerie, quei meandri che a più di cento metri di profondità tutti noi speravamo di incontrare, di intercettare.
Ma la storia delle esplorazioni dell’Abisso della Vendemmia non si fermano qui, perché se è vero che prosecuzioni già pronte all’uso non ne avevamo individuate, è altrettanto evidente che un paio di punti caldi, di possibili accessi, li avevamo comunque visti. Uno in ognuna delle due caverne.
E proprio da quello intravisto nella prima verranno le prossime soddisfazioni, quelle soddisfazioni che ci porteranno, dopo una serie infinita di uscite, di budelli da allargare, di ripiani da riempire di materiale, a individuare altri “pozzoni”, altri salti larghi, comodi, interessati da stillicidio e fango, tanto fango, fino a raggiungere il fondo attuale dell’abisso, a circa –200 metri, costituito da un laghetto permanente assolutamente splendido.
Ma questa sarà la storia che racconterà qualcun altro, qualcuno che ha vissuto di persona queste emozioni.
Paolo










Lascia un commento